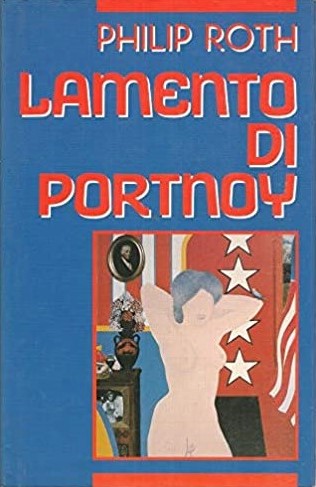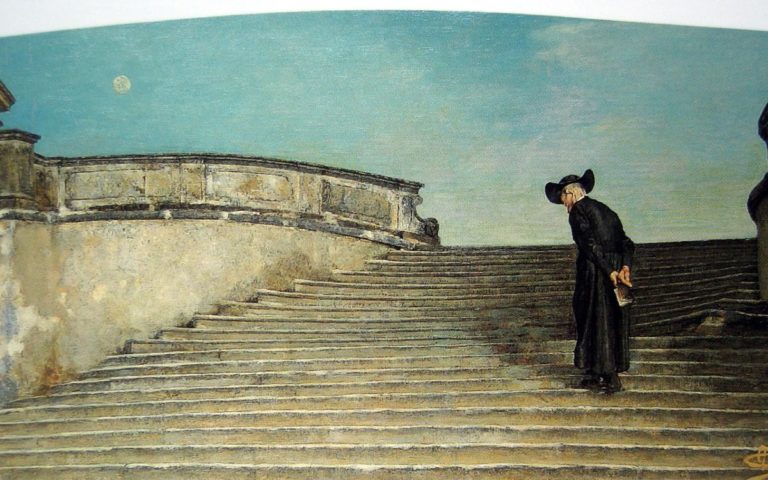Onirico, visionario, immaginifico, Jheronimus Bosch è conosciuto in ogni angolo del globo e la sua fama travalica ampiamente i confini del mondo dell’arte. Eppure le opere che gli sono unanimemente attribuite sono molto poche, e riunirle in un unico luogo è stata finora un’impresa pressoché impossibile. Ci sono riusciti gli organizzatori della grande mostra presentata oggi a Palazzo Reale, a cura di Bernard Aikema, già professore di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Verona, Fernando Checa Cremades, docente di Storia dell’Arte all’Università Complutense di Madrid ed ex direttore del Museo del Prado, e Claudio Salsi, direttore Castello Sforzesco, Musei Archeologici e Musei Storici, nonché docente di storia dell’incisione presso l’Università Cattolica di Milano. Per trasformare il progetto in realtà sono stati necessari cinque anni e un imponente lavoro di ricerca e cooperazione culturale internazionale, frutto degli sforzi congiunti di Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e Castello Sforzesco con 24 Ore Cultura. Il risultato è “una mostra unica per la potenza del racconto di un’intera epoca artistica e per l’importanza e la varietà dei confronti” presentati, spiegano gli organizzatori. Jheronimus Bosch, Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio, 1500 circa. Olio su tavola. Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga © DGPC/Luísa OliveiraDal 9 novembre al 12 marzo 2023, circa 100 opere tracceranno il ritratto di un artista singolare e misterioso, sul quale gli esperti non hanno mai smesso di dibattere, e delle passioni che è riuscito ad accendere dal Cinquecento ad oggi, influenzando grandi maestri, attraendo prestigiosi collezionisti e dando vita a un gusto diffuso che autorizza a parlare di un vero e proprio “fenomeno Bosch”. L’affascinante tesi dei curatori è che il pittore fiammingo, così diverso dagli altri grandi artisti dell’Europa del suo tempo, sia l’emblema di un Rinascimento “alternativo”, lontano anni luce dagli ideali umanisti e classicisti del XV secolo, e dunque la prova dell’esistenza di una pluralità di Rinascimenti, ciascuno con proprie caratteristiche e un proprio centro di gravità. Altra ipotesi fondante è l’idea che il “fenomeno Bosch” non nasca nelle Fiandre, patria dell’artista, ma nel mondo mediterraneo, e precisamente tra la Spagna e l’Italia del Cinquecento. Bottega di Jheronimus Bosch, La visione di Tundalo, 1490-1525 circa. Olio su tavola. Madrid, Museo Lázaro Galdiano © Museo Lázaro Galdiano, MadridProprio per questo la mostra milanese non è una tradizionale monografica, bensì un dialogo fluido tra le opere di Bosch e quelle di maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, che evidenziano come “l’altro Rinascimento” abbia in seguito influenzato artisti di estrazioni diverse, da Tiziano a Raffaello, da Gerolamo Savoldo a El Greco. Lungo il percorso troviamo dipinti, sculture e incisioni, ma anche arazzi, volumi antichi e oggetti rari provenienti dalle wunderkammer di facoltosi collezionisti. Tra i capolavori di Bosch spicca il monumentale Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio del Museu Nacional d’Arte Antiga di Lisbona, mai stato esposto in Italia,che nel corso del Novecento ha lasciato il Portogallo soltanto due volte, mentre proviene dal Groeningenmuseum di Bruges il Trittico del Giudizio Finale, anticamente nelle collezioni del cardinale veneziano Marino Grimani. Altri prestiti straordinari sono arrivati dal Museo del Prado, dal e dal Museo Làzaro Galdiano di Madrid e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Jheronimus Bosch, Le Tentazioni di Sant’Antonio, 1500 circa. Olio su tavola. Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga © DGPC/Luísa OliveiraSenza precedenti è l’esposizione dell’intero ciclo degli arazzi tratti dalle opere di Bosch, che accosta per la prima volta i quattro pezzi del Monastero dell’Escorial e il cartone del quinto arazzo andato perduto, conservato nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi: oggetti d’arte preziosissimi, autentici status symbol nell’Europa cinquecentesca, che oggi testimoniano la fortuna dell’artista fiamminghi presso i vertici dell’aristocrazia dell’epoca. Copia da Jheronimus Bosch, Scena con elefante, XVI secolo. Olio su tela. Firenze, Gallerie degli Uffizi © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli UffiziLe incisioni, a partire da quelle di Pieter Bruegel il Vecchio, furono invece il medium principale grazie al quale l’immaginario fantastico e notturno di Bosch viaggiò lungo tutto il continente, e perfino oltre l’Atlantico. Nelle corti del XVI e XVII secolo, infine, il gusto bizzarro dell’artista fiammingo si accordò perfettamente con lo spirito delle wunderkammer: lo scopriremo nell’ultima sala di Bosch e un altro Rinascimento, allestita proprio come una camera delle meraviglie, dove oggetti rari e preziosi evocano le atmosfere del più celebre capolavoro di Bosch, il Trittico del Giardino delle Delizie. Manifattura di Bruxelles, Il giardino delle delizie, 1550-1570 circa. Arazzo. Madrid, Patrimonio Nacional, Palacio Real © Patrimonio Nacional, Madrid