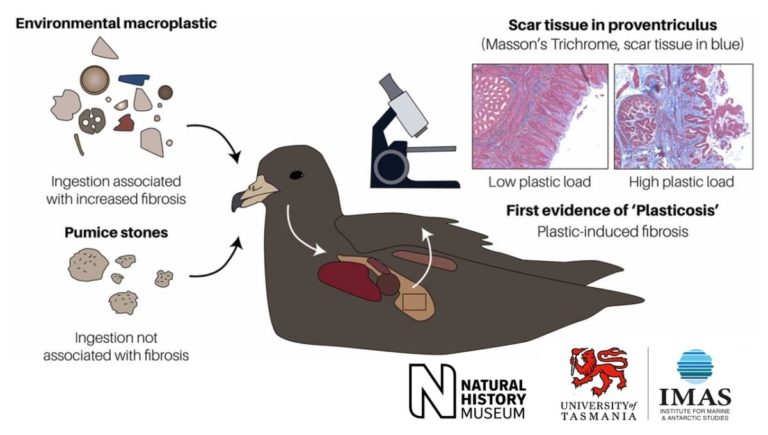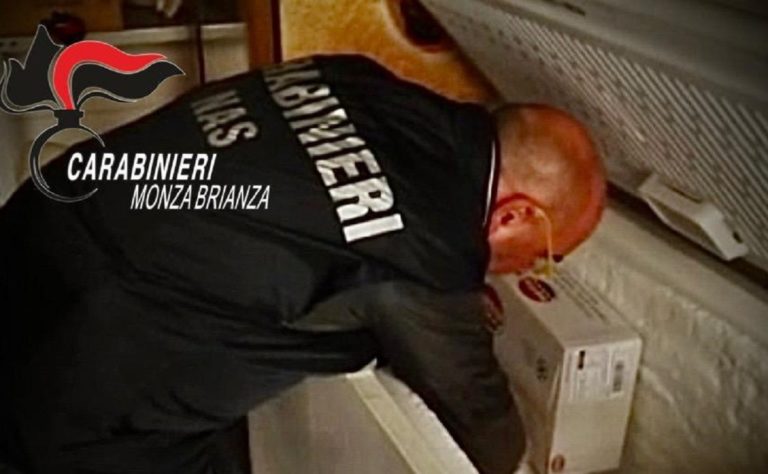Secondo lo studio “Il Valore dell’Attività Venatoria in Italia”, curato da Nomisma e presentato ieri dalla Federazione Italiana della Caccia in Senato, il b calore ambientale della caccia in Italia è di un miliardo: «708 milioni di euro di valore naturale generati dal mantenimento delle aree umide, degli habitat e dalla tutela delle aree naturali protette resi possibili grazie a finanziamenti e gestione del mondo venatorio. 20 milioni di euro di valore agricolo derivanti dai risarcimenti agli agricoltori per danni da selvatici e/o per misure di prevenzione. 75 milioni di euro di risparmi derivanti dalla riduzione dell’impronta ecologica e idrica prodotte dalla filiera della carne». E’ evidente il tentativo di far passare i danni all’agricoltura per risorse. La “pronta caccia” per gestione ambientale e il goffo tentativo di contrapporre la carne sostenibile di selvaggina a quella insostenibile degli animali di allevamento. Il tutto assicurando che «Il mondo venatorio, da tempo impegnato in un percorso di rafforzamento del proprio ruolo in chiave più etica e sostenibile, è in grado di generare un valore di circa 8,5 miliardi di euro annui per la collettività in termini economici e ambientali».
Ma leggendo attentamente lo studio/rapporto/sondaggio (e distinguendo le pere dalle mele mischiate ad arte) viene fuori che il valore economico- sociale della caccia è in realtà molto ridotto e che i cacciatori spendono la grandissima parte di quelli che si vorrebbero far passare per generosi investimenti economico-ambientali solo per armi, munizioni, abbigliamento, auto, cani, vacanze di caccia, ecc. e che, per difendere la carne di selvaggina, si mostra in realtà la crescita di contrarietà agli allenamenti intensivi soprattutto da parte della stessa fetta di opinione pubblica che è contraria alla caccia.
Questo dei cacciatori di selvaggina fatta passare per carne “sana” e poco conosciuta come valida alternativa alla carne “industrializzata” è un cambiamento di immagine che i cacciatori danno di sé stessi: si passa dal cacciatore sportivo e disinteressato a rifornire sottobanco i ristoranti (attività spesso attribuita solo ai bracconieri, anche se la realtà è ben diversa) al cacciatore del nuovo corso politico italico che si fa fornitore del mercato della carne per risolvere il problema degli ungulati, un problema che ha creato una politica venatoria scellerata di immissioni e allevamenti che non viene messa in dubbio né dallo studio né dalle nuove politiche del governo Meloni-Lollobrigida-Pichetto Fratin. Il problema è che rifornire una filiera di mercato economicamente sostenibile bisogna mantenere il problema – cinghiali ad esempio – che si dice che sarà risolto con la caccia. Un cane che si morde la coda della sostenibilità sociale e ambientale.
Ma si parte da una mutazione dei consumi verso un minor consumo di carne – evidente anche nello studio - per rilevare che «Tra i 45 milioni di maggiorenni che si nutrono di carne il 62% consuma anche selvaggina. Nella maggioranza dei casi si tratta di un consumo che avviene prevalentemente fuori casa (nel 39% dei casi al ristorante). Queste interessanti prospettive per la filiera alimentare della selvaggina sono rafforzate dal fatto che ben 23 milioni di consumatori italiani (il 51%) si dichiara pronto ad acquistarla per consumo domestico se fosse di più facile reperimento. Gli intervistati, inoltre, risultano particolarmente attenti e sensibili nell’attuare comportamenti sostenibili nelle proprie scelte alimentari. Rispetto alla carne acquistata, il 72% ritiene molto importante il fatto che presenti meno rischi per la salute e il 70% che provenga da una filiera tracciabile (sic!). Inoltre, il rispetto del benessere degli animali e dell’ambiente è ritenuto condizione imprescindibile dal 64% del campione, così come il 61% degli intervistati è attento al fatto che la carne non provenga da allevamenti intensivi. Il 47% considera importante che la carne acquistata sia naturale e provenga da animali selvatici e non di allevamento».
Lo studio, che divide generosamente a metà gli italiani tra contrari e favorevoli alla caccia (altri sondaggi e studi danno una schiacciante percentuale di contrari), si lamenta però che sulla caccia «Di base è presente una forte disinformazione tanto che ben 2 italiani su 3 si dichiarano non sufficientemente informati sulla tematica e solo 1 intervistato su 10 afferma di conoscere appieno norme e disposizioni che ne regolano l’operato. Rispetto ai soggetti dai quali gli italiani vorrebbero ricevere informazioni, il 60% degli intervistati individua gli enti pubblici come realtà autorevole e adeguata a fornire tali informazioni». Peccato che gli enti pubblici facciano spesso disinformazione, come dimostrano le dichiarazione carpite al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante un incontro coi cacciatori in campagna elettorale.
Ma, per quanto edulcorato, anche lo studio/ricerca/sondaggio dice che gli italiani sono contrari alla caccia e che non ci vedono tutte queste ricadute economiche e sociali che vengono evidenziate da Federcaccia.
Ma Marco Marcatili, responsabile sviluppo di Nomisma, la vede in tutt’altro modo è perllui il bicchiere venatori è più chre mezzo pieno: «Per la prima volta il sistema della caccia decide di aprirsi alla società, ascoltare la comunità e avviare un dialogo aperto e trasparente con il mondo istituzionale, agricolo e ambientale. Il lavoro di Nomisma – spiega Marcatili – è, da un lato, rassicurante perché conferma la non ostilità alla caccia, anzi una inedita apertura della comunità a inserire più selvaggina sostenibile nella propria alimentazione; dall’altro lato, però, induce la Federazione Italiana della Caccia a una responsabilità aumentata in termini di maggiore informazione e disponibilità alla caccia etica e sostenibile. Non sono molte in Italia le attività che danno un contributo annuale di 1 miliardo in termini ambientali, l’impegno in questa direzione consentirà di traguardare opportunità derivanti dai nuovi scenari climatici, come il presidio dei territori fragili e il rafforzamento delle filiere nazionali sotto il profilo alimentare e occupazionale».
Ma Nomisma ammette che dalla lettura dei risultati e delle interviste emergono anche aree di miglioramento meritevoli di attenzione.
Come sia nato il sondaggio lo spiega bene il presidente nazionale di Federcaccia Massimo Buconi: «Abbiamo deciso di affidare a Nomisma un primo bilancio ambientale dell’attività venatoria in Italia al fine di misurare il reale valore generato per Comunità e Ambiente e indagare il percepito delle famiglie italiane sul nostro operato. Siamo certi che favorire una migliore comprensione delle dinamiche che regolano i rapporti tra caccia e società possa concorrere a un giusto riconoscimento del nostro ruolo e della nostra attività, alla luce degli effetti positivi derivanti da una caccia etica e sostenibile. I risultati mostrano un sistema importante già in essere testimoniando il nostro potenziale ruolo di attori nel processo di transizione ecologica, ma evidenziano alcune aree di miglioramento, su cui strutturare un percorso di confronto con fruitori, stakeholders e Istituzioni. Intendiamo proseguire in questa direzione di dialogo, in modo costante e incisivo».
E, dopo le reiterate richieste di allungare i calendari venatori, sparare a specie protette, rigettare le normative europee, consentire la caccia nei Parchi Nazionale e nelle ZSC/ZPS, dopo che l’Italia risulta tra i peggiori pasesi del mondo per bracconaggio/abbattimento dell’avifauna migratoria.., è abbastanza spericolato che lo studio – sulla base di una senzazione di cittadini dei quali si ammette la scarsa conoscenza della materia - nomini i cacciatori «“Sentinella del territorio” (o più tecnicamente “citizen as sensor”), in quanto soggetti volontari coinvolti nei programmi di monitoraggio delle risorse naturali per migliorarne la gestione e contribuire alla ricerca. Così come viene evidenziato il contributo che il mondo venatorio è in grado di rendere alla collettività attraverso programmi di gestione faunistica, tutela ambientale e sorveglianza sanitaria esercitata da cacciatori volontari». E qui il “successo” del ruolo svolto dalla caccia consumistica è evidente con la proliferazione dei cinghiali ibridati, la diffusione della peste suina, e l’immissione di specie alloctone e/o ibridate per la pronta caccia che hanno provocato l’estinzione locale di specie autoctone.
E, viste le proposte fatte fin qui dal mondo venatorio su calendari, aree protette, caccia ai grandi carnivori viene davvero da pensare che ci sia bisogno di ascoltare chi ritiene necessario di «Sostenere una “caccia etica”, che non solo rispetti i regolamenti ma, soprattutto, favorisca il contenimento e il controllo delle attività illegali, promuovendo e consolidando un ruolo attivo del cacciatore nella tutela di ambiente e habitat. Altro ambito di miglioramento è rappresentato dalla sensibilizzazione del sistema venatorio nel suo complesso sulle azioni di contenimento degli impatti ambientali e su un maggiore sviluppo di un modello di caccia che sia in equilibrio con la biodiversità. A livello organizzativo e gestionale, infine, il settore venatorio italiano può mirare a una dimensione adattiva che permetta di modulare prelievi di selvaggina sulla base di un principio di sostenibilità, potenziando il monitoraggio e la programmazione dei piani di caccia e di controllo. Ciò concorrerebbe a consolidare la compatibilità tra attività venatoria e conservazione della fauna e dell’ambiente».
Ma la caccia etica – con buona pace dello studio Nimisma - Federcaccia - non è certamente quello di cui i cacciatori discutono con politici come Fontana.
L'articolo Il valore economico della caccia italiana sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.