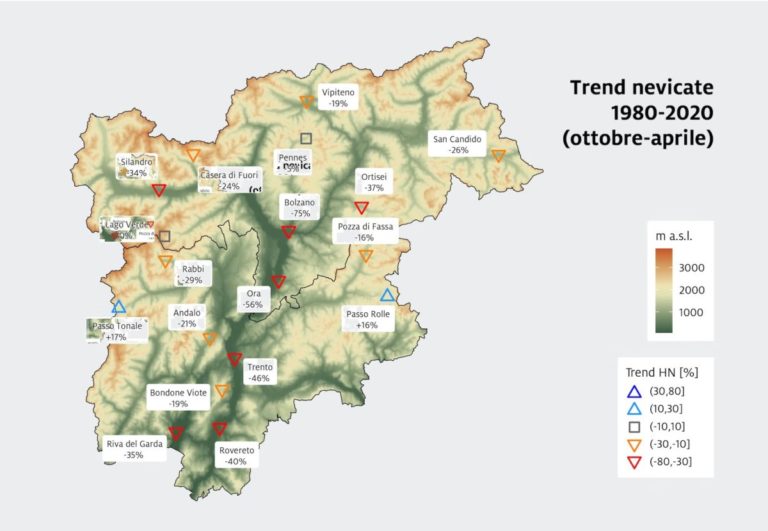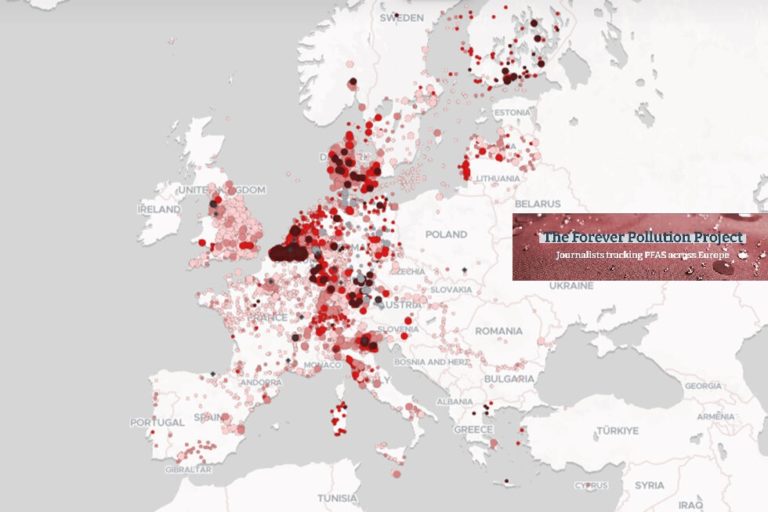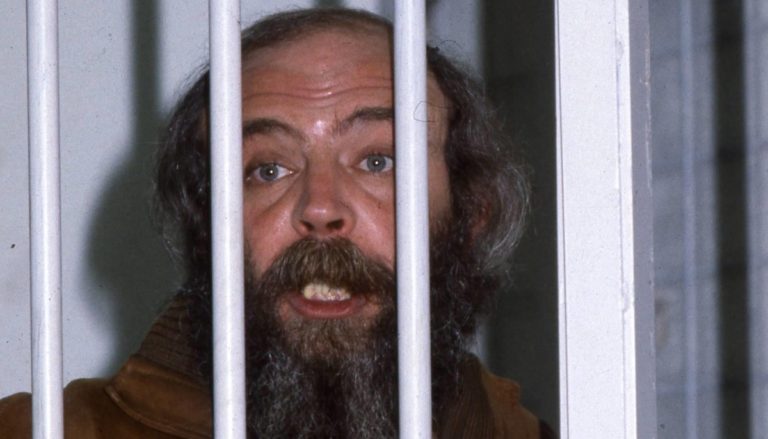Secondo il rapporto “Europe and Central Asia – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022” pubblicato da Fao, International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unicef, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), World Food Programme (WFP); Regional Office for Europe dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e World metorological organization (Wmo), «In Europa e Asia centrale, la pandemia Covid-19 tutt’ora in corso e la guerra in Ucraina mettono in pericolo la sicurezza alimentare e il diritto a un’alimentazione sana. I prezzi dei generi alimentari sono saliti alle stelle, rendendo difficoltoso per i responsabili delle decisioni garantire l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno». Ma il rapporto evidenzia anche che «I dati e le tendenze degli ultimi anni tratteggiano un quadro della sicurezza alimentare e della nutrizione perlopiù incoraggiante in Europa e Asia centrale. In generale, la regione versa in condizioni migliori rispetto ad altre aree del mondo, benché siano necessari miglioramenti per evitare battute d’arresto».
Il rapporto elaborato dalle 8 agenzie Onu fornisce indicazioni preziose per aiutare a far fronte a questa situazione e contiene informazioni e analisi aggiornate sui trend a livello regionale e sui progressi compiuti verso il conseguimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) “Fame zero”. Inoltre, riporta studi sulla definizione di «Quadri strategici che consentano di favorire l’accesso a un’alimentazione sana e di rendere i sistemi agroalimentari più sostenibili dal punto di vista ambientale nella regione di Europa e Asia centrale».
Le agenzie Onu sottolineano che «Avvalendosi dei dati e delle raccomandazioni contenuti nel rapporto, i paesi dovrebbero essere nelle condizioni di fornire assistenza ai piccoli agricoltori, alle comunità rurali e a tutti gli attori della filiera alimentare, nonché di sostenere le fasce povere e vulnerabili della popolazione tramite programmi olistici, secondo quanto previsto negli SDG. Come per le precedenti edizioni della Rassegna regionale della sicurezza alimentare e della nutrizione in Europa e Asia centrale, ci auguriamo che il rapporto fornisca conoscenze e riscontri preziosi e contribuisca a individuare alternative per un dialogo consapevole e un'azione concertata da parte di tutti i partner, in un contesto di piena collaborazione, tesa ad accelerare i progressi verso l’obiettivo della fame zero e dell’accesso a un’alimentazione sana in Europa e Asia centrale».
Il rapporto evidenzia che «La prevalenza della sottoalimentazione nel mondo è salita al 9,9% nel 2020 e, da allora, non ha smesso di crescere, mentre negli oltre 50 Paesi dell’Europa e dell’Asia centrale la media è rimasta al di sotto del 2,5% negli ultimi anni. Inoltre, sebbene in alcune zone della regione (Caucaso, Asia centrale e Balcani occidentali) la porzione di popolazione classificata come sottonutrita sia in aumento, e non si prevedano inversioni di rotta, la media regionale dovrebbe attestarsi al di sotto del 2,5%».
Dopo un brusco rialzo nel 2020, la prevalenza regionale dell’insicurezza alimentare moderata o grave è tornata a salire dall’11,% nel 2020 al 12,4% nel 2021, un dato che secondo il rapporto «Riflette un deterioramento della situazione per le persone che si trovano in gravi difficoltà a causa della pandemia Covid-19. Nel complesso, nel 2021, circa 116,3 milioni di persone, nella regione, versavano in condizioni di insicurezza alimentare moderata o grave; di queste, 25,5 milioni sono stati segnalati in soli due anni. Il numero delle persone vittime dell’insicurezza alimentare grave, ossia che non hanno regolarmente accesso a una quantità sufficiente di cibo nutriente, ha subito un’accelerata, aumentando di oltre 13 milioni dal 2019 al 2021».
Il dato positivo è che in Europa e Asia centrale, «I ritardi della crescita (un basso rapporto tra età e altezza) e il deperimento (causato da un apporto insufficiente di nutrienti all’organismo) interessano, rispettivamente, il 7,3% e l’1,9% dei bambini di età inferiore ai 5 anni, mentre, nel resto del mondo, tali condizioni colpiscono un numero di bambini tre volte maggiore».
Ma nella regione Europa e Asia centrale «Il sovrappeso e l’obesità continuano a essere fenomeni allarmanti, sia tra bambini che tra gli adulti, con dati superiori alla media globale». E il rapporto avverte che «A causa del rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari, il costo di un’alimentazione sana è aumentato in quasi tutti i paesi dell’Europa e dell’Asia centrale. Nonostante ciò, ad eccezione di alcuni Paesi, la maggior parte della popolazione della regione (approssimativamente il 96,4%) ha potuto permettersi un’alimentazione sana, rispetto alla media del 58% della popolazione mondiale nel 2020. Alcuni Paesi importatori netti e a basso e medio reddito della regione (tra cui Armenia, Kirghizistan e Tagikistan) hanno una percentuale molto alta di popolazione (oltre il 40%) che non può permettersi una dieta sana».
Il rapporto ricorda che «I Paesi della regione si caratterizzano per livelli di sviluppo diversi, così come diverso è il sostegno finanziario che essi assicurano al settore alimentare e agricolo. Inoltre, la maggior parte di questi paesi, soprattutto quelli a medio reddito, sono stati particolarmente colpiti dalle criticità emerse di recente, a livello regionale e globale, e non possono fare affidamento su maggiori capacità di investimento nei sistemi agroalimentari, come ricetta per superare la crisi».
Per questo le agenzie Onu evidenziano che «Occorre rimodulare le politiche alimentari e agricole, in modo da renderle più adatte ad affrontare la “triplice sfida” a cui sono attualmente esposti i sistemi agroalimentari, vale a dire potenziare l'accesso a un’alimentazione sana, garantire mezzi di sostentamento migliori agli agricoltori e promuovere la sostenibilità ambientale. Per conseguire questo traguardo, non sarà sufficiente offrire incentivi fiscali ai singoli agricoltori, ma occorrerà ottimizzare i servizi generali, con interventi mirati nei settori della ricerca e dello sviluppo agricoli e dell’istruzione, con misure di espansione, con azioni di controllo di parassiti e malattie, con l’adozione di sistemi pubblici di controllo della sicurezza alimentare, nonché con la promozione di un'agricoltura climaticamente intelligente e di tecnologie e pratiche più efficienti in termini di emissioni».
Secondo il rapporto, «Ripensando le attuali strutture di sostegno agricolo, sarà possibile incoraggiare anche il consumo di alimenti sani, primi fra tutti frutta, ortaggi e legumi. Nel definire il quadro per lo sviluppo di sistemi agroalimentari più sani, sostenibili, equi ed efficienti, non sarà, tuttavia, sufficiente limitarsi alle politiche agricole. Per avere azioni di rimodulazione degli obiettivi capaci di incidere nella regione, occorrerà, invece, ampliare lo spettro, fino a includere anche politiche complementari nel campo della sanità, della protezione sociale, del commercio e dell'ambiente. Soprattutto per quanto concerne la sostenibilità ambientale e una maggiore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i responsabili delle decisioni dovranno pensare in maniera olistica e facilitare l’applicazione di tecnologie e pratiche basate sulla scienza, climaticamente intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico lungo tutta la filiera agroalimentare».
Il rapporto conclude: «Per avere successo, è fondamentale che tutti questi interventi tengano conto, in particolare, delle circostanze locali e rispettino il principio della partecipazione».
L'articolo Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione in Europa e Asia centrale sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.