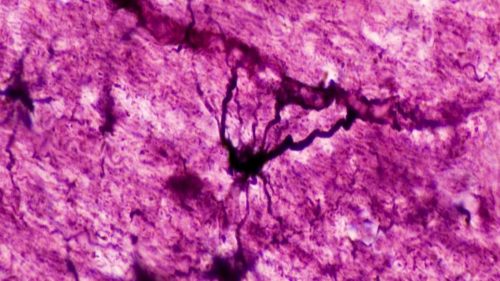Gli incubi più ricorrenti in tutto il mondo secondo gli scienziati

Nonostante le differenze di cultura e background, alcuni incubi sono più ricorrenti di altri. A chi non è mai capitato di svegliarsi nel cuore della notte a causa di un incubo spaventoso? Cosa c’è dietro queste elaborazioni della nostra mente? Michael Schredl, a capo del laboratorio del sonno presso l’Istituto Centrale di Salute Mentale di […]
L'articolo Gli incubi più ricorrenti in tutto il mondo secondo gli scienziati sembra essere il primo su Scienze Notizie.