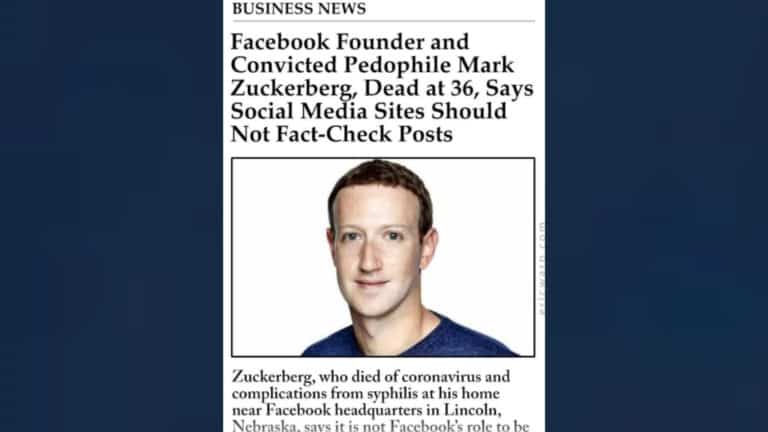Vinicio Marchioni: «Vinco la balbuzie recitando. Felicità è lavorare il legno nella bottega di mio suocero»

L’attore: «Noi di Romanzo criminale siamo rimasti legati». La famiglia: «Mio papà era il segretario personale di Fanfani, poi si è licenziato, ha comprato un camion e si è messo a fare l’autotrasportatore». Il passato: «Ho pensato di mollare e fare il fotografo»
L’arma segreta di Vinicio Marchioni
è una bottega in un’area di quello che un tempo era l’agro romano, alle spalle del Vaticano. «Era di mio suocero, falegname, maestro d’ascia, restauratore, antiquario, a cui ero molto legato. Ho bisogno di sentire la fatica, sono uno che se non suda non sono soddisfatto. Quando ho bisogno di silenzio, mi chiudo lì e inizio a faticare». Ogni tanto i risultati li posta sui suoi profili, come le sedie con un’intelaiatura in acciaio che l’ha fatto patire. O i lavori di manovalanza al servizio della moglie Milena Mancini. «È lei l’artista di casa, io magari metto sui social, lei bada al concreto. La passione per la manualità l’ha trasmessa anche ai nostri figli», precisa. «Il pezzo di cui vado più fiero? Non l’ho ancora realizzato. Vorrei fare uno di quei tavoloni con grandi tavole di legno e resine, prima o poi ci riesco». 47 anni il prossimo agosto, sposato da una decina con Milena, padre di Marco e Marcello, ha i suoi buoni motivi per chiudersi a scartavetrare. Tra teatro (Chi ha paura di Virginia Woolf? di Antonio Latella, I soliti ignoti di cui ha curato la regia), cinema (Supereroi di Paolo Genovese, Ghiaccio di Fabrizio Moro e Alessio de Leonardiis, Siccità di Paolo Virzì, L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, Vicini di casa di Paolo Costella, Buon Viaggio ragazzi di Riccardo Milani) e tv (la serie Django di Francesca Comencini) ha alle spalle mesi di una stagione intensa. «Per due anni non mi sono fermato un giorno. Ora ho bisogno di lavoro fisico, sapere che devo dipingere dal punto A al punto B. Niente di meglio per me».
Come è arrivato a fare l’attore?
«Per sbaglio. Ero iscritto a Lettere, ma avevo anche fatto domanda al Centro sperimentale, per regia e sceneggiatura, mi immaginavo raccontatore di storie. Lungi da me fare l’attore. Per la seconda annualità di storia del teatro chiesi al professore di consigliarmi un posto dove vedere la pratica. Mi diede alcuni indirizzi e mi trovai a via degli Zingari in uno strano luogo, la Libera accademia dello spettacolo, direttore Riccardo Garrone, e lì mi sentii a casa. Non me ne sono più andato. Per pagarmela ho fatto il segretario e poi sono entrato in compagnia: da quelle tournée è iniziato tutto il resto».
Che cosa l’ha fatta sentire a casa?
«Cercavo l’espressione di me, credo. Il fatto che io sia balbuziente conta: già a scuola mi sono reso conto che non lo facevo più alle recite ma ancora non pensavo di fare l’attore. Dopo è esploso il mondo: i classici, i libri, la musica, la consapevolezza di sé, gli incontri».
A casa come l’hanno presa?
«Mia madre mi ha sempre lasciato fare tutto. Ho sempre voluto raccontare, sono un grafomane, scrivevo diari fin da bambino, sentivo la necessità di ricreare dei mondi. Mi ha sempre lasciato fare anche a costo di sbatterci le corna. Un solo consiglio da lei: segui l’istinto».
È cresciuto a Fidene, periferia nordest di Roma.
«Mio nonno e mio padre la chiamavano Montesecco perché non c’era l’acqua ed era più alta rispetto a via dei Prati Fiscali. Il nonno era arrivato da un paesino in provincia di Rieti in cerca di fortuna, scavando le fondamenta per costruire una casa di famiglia. Trovò una vena d’acqua e da una baracca di blocchetti costruì quattro appartamenti dove sono cresciuto con le zie. I ricordi d’infanzia sono di una famiglia unitissima, di origine agricola e di operai. Il nonno poi, stufo di stare in mezzo agli altri, si prese un pezzo di terra verso Palombara sulla Salaria, con fattoria e animali. Oggi dici fattoria e pensi a una cosa chic, no quella era fatta con i blocchetti, quello che si trovava, con la puzza degli escrementi delle galline. Vera cultura contadina. Quando ci fu l’incidente di Chernobyl, a scuola comprensibilmente c’era un’aria di catastrofe. Andammo lì nel fine settimana, e mia nonna: “Che ci frega, noi abbiamo la cantina piena”. Mi ricordo quel senso di protezione. Poi con gli anni ho capito».
Cosa?
«Mio nonno era uno di quegli uomini che trattava meglio gli animali di figli e nipoti, come tanti dell’epoca. L’ho apprezzato con il tempo, ci faceva assaggiare la terra per sapere se ci si poteva coltivare, si tagliava i capelli con la luna calante, non faceva niente se non guardava la luna. Ho una mentalità diversa dalla sua ma ancora oggi ho un forte contatto con la natura, mi ricarica. Mi ricordo da dove vengo».
E suo padre?
«Un uomo eccentrico. Era il segretario personale di Amintore Fanfani, poi si è licenziato, ha comprato un camion e si è messo fare l’autotrasportatore. Dopo la sua morte è stato il disastro completo. Io e mio fratello eravamo ragazzi, si è sfasciato tutto, anche la mia idea di famiglia».
Con Milena Mancini ne ha costruita una che dà l’idea di solidità.
«Abbiamo avuto fortuna, ci teniamo. Le camere oscure le abbiamo tutti, per mestiere frequentiamo luoghi dell’anima pericolosi. Ci siamo conosciuti ai tempi della seconda stagione di Romanzo criminale, lei venne per i provini. L’ho vista e mi sono fermato lì, c’è poco da dire. Ho messo in moto anche cose subdole per rivederla. Eravamo tutti e due in un momento abbastanza complesso sentimentalmente. Nella coppia è fondamentale il rispetto, la stima. Guardarla e pensare: mamma mia che brava. Io mi innamoro dei talenti, follemente. Sei mesi dopo stavo da lei. Dopo un anno mezzo è arrivato il nostro primo figlio, poi il secondo. Una storia semplice la nostra».
Ha citato «Romanzo criminale». Molti lo considerano il suo inizio, in realtà c’era già stato altro, per esempio Luca Ronconi.
«Nel 2005, dopo quattro anni di tournée con la compagnia, spettacoli in teatri off. Sono arrivato da Ronconi al Centro Santa Cristina ancora ingenuo, senza neanche un agente. Avevo solo capito cosa non volevo fare: mettermi in situazioni non mie. Con lui ho vissuto un’esperienza straordinaria. È stato un grande maestro di autorevolezza, mi ha insegnato il carisma che questo mestiere può avere. Cosa voglia dire essere interprete, ovvero riportare in vita lettera morta, fare da tramite per chi non conosce quella lingua. Sono stato due anni in compagnia con lui».
Poi è arrivata la serie di Sollima.
«Uno tsunami. Prima avevo fatto giusto tre pose per Distretto di polizia che ricordo come l’esperienza più terrorizzante della mia vita».
Oddio, perché?
«Non avevo idea di cosa significassero macchina da presa, regole e tempi del set, mi sembravano tutti matti. Non capivo, ero l’ultima ruota del carro. Azione! Stop! Io stavo facendo le prove con Roberto Latini per uno spettacolo e mi chiamarono per i provini della serie. Merito di Placido che era venuto a vedere un mio spettacolo anni prima e mi aveva chiamato per i provini per “ll Freddo” del film. Poi non mi ha preso. Però Michele fece da supervisore per i provini per la serie e la parte fu mia. Me lo ricordo come un sogno. Scioccato da gigantografie sui palazzi di Roma: ma che sono io? Mi ha insegnato la volatilità di questo mestiere. Interviste, titoli, attenzione ma era come se mi avessero trovato per strada. Io pensavo: voi non lo sapete ma io esistevo pure prima, ho fatto altro. E dopo, per reazione, sono tornato in palcoscenico, ho rifiutato altre serie, ho scritto un monologo su Dino Campana e mi sono chiuso in un teatrino».
Con gli altri della banda siete rimasti legati?
«Certo. Come se avessimo fatto il militare insieme, abbiamo condiviso sette mesi il primo anno, sette il secondo più le prove. Se non avessi avuto l’esperienza teatrale non ci avrei messo quell’intensità. Mi addormentavo la sera sulle scene per il giorno dopo. Una faticaccia. Ma set straordinario».
Ha ritrovato Placido per il suo Caravaggio.
«È un grandissimo. Sapevo che prima o poi avremmo lavorato insieme. Caravaggio lo stava studiando da anni. Nel cast ci sono Louis Garrell e Isabelle Huppert. Bellissimo. Quelli bravi sono pratici, semplici».
Com’è stata l’esperienza di «Chi ha paura di Virginia Woolf»?
«Come entrare in un consesso straordinario con grandi come Antonio Latella e Sonia Bergamasco che ti aprono porte. Lei ha insistito che fossi io. Ci stimavamo molto. Sonia è un’attrice stratosferica e fa troppo ridere, è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via, mette in moto energie. Nei Paesi anglosassoni alternare teatro e cinema è sinonimo di orgoglio e qualità, qui ancora mi chiedono se preferisco cinema o teatro. Andatelo a chiedere a Benedict Cumberbatch, rispondo».
Il suo più grande errore?
«Non c’è. Le cose vanno come devono andare. Se non rientri nell’immaginario di un regista, pazienza».
Molto zen.
«No, molto calabrese. È la mia parte materna, chi mi ha sempre fatto stare tranquillo sulle mie possibilità. È andato male questo provino? Ne arriverà un altro. Non devi mettere in giro energia brutta, ma lasciare andare le cose e cercarne altre. Il paese di mia madre è Torre Melissa, lo frequento fin da piccolo. Lì stanno i miei migliori amici. Sono quattro, ci conosciamo da 40 anni. Uno è fotografo e nei tempi bui, quando non succedeva niente e pensavo di mollare tutto e trasferirmi in Calabria, gli facevo da assistente ai matrimoni. Mi dispiace che nessuno ricordi che sono mezzo calabrese. Solo Fabio Mollo con cui ho fatto Il sud è niente, bellissimo film girato a Reggio. Faccio un appello: parlo bene il dialetto. Anche altri in verità».
In «Django» è un colonnello sudista italiano.
«È la seconda serie che faccio. È un’operazione pazzesca, in costume, attori di tutte le nazionalità, grandi mezzi, prove. Un’esperienzona».
Programmi?
«Ora mi prendo il lusso di fermarmi un po’. Il progetto giusto, il regista giusto, i colleghi giusti. Tornare indietro, ma perché?».
Alla peggio costruirà un nuovo mobile.
«Ma infatti. Se mi cercate sono qua».