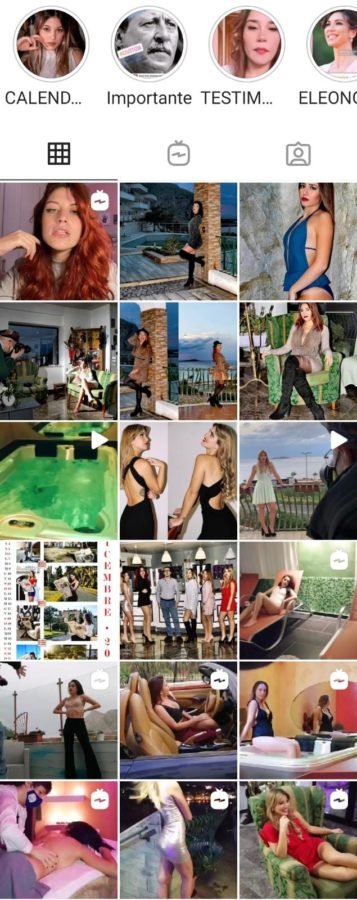Ditta Europea Umilty di Salvatore Luca Longo: “Quando non si hanno certezze si rischia la diffamazione provocando danni”
Le dichiarazioni mendaci rappresentano un tema di grande attualità in un periodo quale quello attuale dominato dalle autocertificazioni. In realtà, si tratta di un tema ampio che involge numerose fattispecie penali le quali, a loro volta, si intrecciano al settore pubblicistico.
Quando si parla di dichiarazioni mendaci, facciamo riferimento a tutte quelle ipotesi nelle quali viene affermato un qualche cosa che non corrisponde a verità, in tutto o in parte.
Se vogliamo fare un’esempio attuale, dobbiamo considerare gli ingenti danni economici subiti dalla ditta Europea Umilty di Palermo che, attraverso il giovane imprenditore Salvatore Luca Longo, ha dato lavori occasionali ad almeno 375 ragazze/i tra cui alcune di loro collaborano ancora con aziende connesse alla comunicazione, al marketing, alla grafica, ed alla moda, tra il 2016 ed il 2020.
Aziende che dallo scorso Dicembre non possono più ricevere i servizi professionali erogati dalla ditta Umilty che incontrava le esigenze economiche di titolari in difficoltà a causa dei problemi economici legati alla pandemia da Covid 19. Aiuti aziendali che è possibile anche riscontrare sulle pagine social di Umilty. Chi ci lavorava, guadagnando settimanalmente, si trova adesso in una condizione psicologica di forte disagio causato soprattutto dall’opinione pubblica influenzata da articoli giornalistici che sono andati ben al di la del diritto di cronaca…
Finche la giustizia non fa il proprio corso, ogni dichiarazione od affermazione fatta finché non ci sia una sentenza definitiva, può essere rischiosa per chi la pronuncia e dannosa per chi la riceve, sicuramente il danno per questa ditta è stato notevole in quanto era ben piazzata sul mercato come si può vedere dalle foto nell’articolo.
Non a caso esiste il principio giuridico della presunzione di innocenza secondo il quale un imputato non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario.
Per le tante dichiarazione fatte sui social, nei confronti di un imputato che ancora non è stato dichiarato colpevole, sia da persone che dalla stampa locale vogliamo citare sentenze e normative in merito.
Quindi attendiamo che la giustizia faccia il suo lavoro con tranquillità.
Ecco un dettaglio delle varie sentenze e normative in materia.
La dichiarazione mendace è sanzionata da numerose fattispecie del codice penale. In particolare, le dichiarazioni mendaci sono punite in quanto pericolose per l’amministrazione della giustizia, quando vengono rese all’interno di un procedimento giudiziario, civile o penale, ed in quanto pericolose per la “fede pubblica”. Sotto il primo profilo, è vietato rilasciare false dichiarazioni al pubblico ufficiale, circa l’identità personale (art. 495 cod. pen), è vietato rilasciare dichiarazioni false o mendaci quando si è testimoni in un processo (art. 372 codice penale) o al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen) o al difensore (art. 371 ter cod. Pen.). Si tratta di fattispecie poste dal legislatore a tutela dell’amministrazione della giustizia, in quanto dichiarare il falso, potrebbe ostacolare l’obiettivo di ricostruire la verità storica dei fatti, all’interno di un procedimento civile o penale.
A far chiarezza sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, pronunciandosi a favore della natura plurioffensiva dei delitti di falso, ha affermato l’opportunità di doversi intendere per “fede pubblica” l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti (Cass. S.U. sent. n. 46982/2007). Affinché la dichiarazione mendace risulti essere meritevole di sanzione, occorre anche la sussistenza del dolo da parte dell’autore. Detto altrimenti, ciò significa che colui il quale pone in essere la dichiarazione mendace deve essere consapevole della falsità di quanto dichiarato o rappresentato. Nonostante la giurisprudenza di legittimità e di merito siano da sempre costanti nel ritenere sufficiente il dolo generico ai fini della costituzione del reato di falso, parte di autorevole dottrina ha prospettato l’esigenza di arricchire la struttura del dolo, con la consapevolezza del disvalore sociale del fatto o dell’intenzione di ingannare. Ad argomentare siffatta tesi, è stata avanzata la considerazione secondo la quale il dolo, nei delitti di dichiarazioni mendaci, non potrebbe limitarsi alla coscienza e volontà della trasfigurazione del vero dovendo necessariamente concretizzarsi nella consapevolezza di porre in essere una condotta dotata di rilevanza giuridica.
Le false dichiarazioni al pubblico ufficiale vengono punite dagli artt. 483 e 495 cod. pen., nonché dall’art. 76 dpr n. 445/2000 il quale, al I comma, prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni ordinariamente contemplate dal codice penale, ogni qual volta siano rilasciate dichiarazioni mendaci o formati atti falsi e, al III comma, equipara le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000 a quelle fornite a pubblico ufficiale. L’art. 495 cod. pen. punisce “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”.
La sanzione prevista è la reclusione da uno a sei anni, e non può essere inferiore a due anni “se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile” oppure “se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.” Dalla lettera della norma, emerge che ai fini dell’integrazione del reato in esame è sufficiente la sola circostanza del rendere dichiarazioni in ordine alla propria o altrui qualità personale non corrispondente al vero, non essendo invece occorrente il dolo specifico di trarre in inganno in destinatario della dichiarazione (Trib. Napoli sent. n. 16580/2014).
Detto altrimenti, affinché le dichiarazioni mendaci assumano rilievo ai sensi dell’art. 495 cod. pen. devono concretizzarsi in dichiarazioni false o mendaci, in ordine ai dati identificanti sé stessi o un altro soggetto. Per comprendere meglio la ratio della norma, si pensi all’esempio a false informazioni rese in relazione allo stato civile o alle proprie generalità, le dichiarazioni mendaci fornite circa la propria residenza, nazionalità o domicilio. Con la riforma apportata alla disposizione dal d.l. n. 92/2008 è scomparso il riferimento all’atto pubblico, sicché è oggi pacifico che il reato sia integrato allorché le dichiarazioni mendaci siano fornite al pubblico ufficiale, prescindendo dalla circostanza che le dichiarazioni mendaci siano preordinate alla formazione dell’atto pubblico.
La novella, inoltre, ha comportato un innalzamento della pena di tal guisa permettendo l‘arresto facoltativo nei casi di flagranza, così come l’irrogazione di misure cautelari. Le dichiarazioni mendaci allorquando siano rilasciate al Pubblico Ministero nel corso di un procedimento penale (dunque anche nella fase delle indagini preliminari) da soggetto chiamato a fornire informazioni utili al buon esito dell’accertamento giudiziario, integrano il reato di cui all’art. 371 bis cod. Pen. Detta disposizione è stata introdotta nel codice penale dalla l. n. 356/1992, nell’intento di arginare il fenomeno della reticenza in ordine al fenomeno mafioso. Malgrado la norma esordisca con la locuzione “chiunque” che parrebbe configurare un reato comune (ossia realizzabile da chiunque), in realtà si tratta di un reato “proprio” giacché le dichiarazioni false o mendaci possono essere resa al Pubblico Ministero unicamente dai “possibili testimoni” che sono sentiti dal giudice inquirente a sommarie informazioni. Per quanto concerne l’elemento psicologico, ai fini del perfezionamento della fattispecie, è sufficiente che le dichiarazioni mendaci siano sorrette da dolo generico, atteso che la condotta penalmente rilevante si sostanzia nel fornire volontariamente dichiarazioni mendaci, cioè raccontando fatti sui quali si indaga in modo difforme dalla realtà storica conosciuta dal dichiarante.
Nella fase investigativa il Pubblico Ministero si avvale della Polizia giudiziaria, delegandole lo svolgimento di atti di indagine. Inoltre la p.g. può svolgere indagini di propria iniziativa, ad esempio, nell’immediatezza del fatto. Di tal guisa, ben può accadere che una persona sia chiamata a rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria anziché al P.M. In assenza di una specifica disposizione codicistica che espressamente sanzioni detta eventualità, a lungo la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate in relazione alla possibilità di sussumere le dichiarazioni mendaci rese alla P.G. nella norma dell’art. 371 bis cod. pen. ovvero in quella della falsa testimonianza di cui all’art. 372 cod. Pen. A favore della tesi che propendeva per l’inquadramento di tali vicende nella fattispecie dell’art. 371 bis cod. pen. militava il rilievo per il quale la P.G., nel chiedere informazioni utili ai fini delle indagini a soggetto che potenzialmente possa esserne al corrente, opera su delega e per conto del P.M. Tuttavia, siffatta estensione ermeneutica è stata espressamente negata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 75/2009 poiché ciò comporterebbe un’interpretazione analogica su norma penale in malam partem con il rischio di una seria compromissione del principio di legalità. Sulla base di tale monito, anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12832/2016, ha ribadito l’impossibilità di detta estensione, pervenendo a sussumere le fattispecie di dichiarazioni mendaci fornite alla P.G. sotto l’egida del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen. il quale, posta anche la sua natura di reato di pericolo, consente un’estensione della punibilità finanche a quelle condotte che, seppur di fatto non abbiamo effettivamente compromesso l’accertamento dei fatti oggetto di indagine, abbiano comunque reso maggiormente gravoso il raggiungimento di detto scopo.
I social network sono diventati l’ambiente virtuale più frequentato al mondo: l’espressione di un pensiero o opinione racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale, che a volte vengono ignorate.
La nostra rete sociale sembra sia costituita da “amicizie virtuali”, like, commenti e continui aggiornamenti dello status o di qualsiasi altra informazione della vita personale, ma anche di quella degli altri. È chiaro ai più che attraverso i social network è permesso “conoscere” fatti, stati emotivi, vicende personali della cosiddetta “cerchia di amici” di cui è composto il profilo personale di Facebook o di Instagram, ad esempio, ma è sempre poco chiaro a chi è “social” quali siano le conseguenze di determinati comportamenti, che potrebbero portare anche alla commissione di illeciti penali. L’evolversi della coscienza “social”, la rapidità diffusoria delle informazioni attraverso Internet, l’impossibilità o comunque la difficoltà di controllare la provenienza e l’autorevolezza delle informazioni hanno posto il problema di individuare il ruolo dell’informazione e della liceità della stessa, così come il rapporto tra ciò che è considerato libertà e spontaneità della informazione e ciò che invece sfocia inevitabilmente nel reato di diffamazione. Veniamo perciò all’individuazione del delitto di diffamazione, previsto all’art. 595 del codice penale: “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata). Gli elementi che distinguono il reato di diffamazione sono pertanto la comunicazione con più persone, intesa come pluralità di soggetti che siano in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato, e poi l’offesa alla reputazione del soggetto che si vuole colpire, in maniera cosciente e consapevole. Una volta individuata la condotta delittuosa, l’articolo fa cenno a elementi aggravanti e in particolar modo richiama il mezzo con cui l’offesa della reputazione altrui può essere commessa, il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. E sono infatti gli elementi della diffusione e della pubblicità attraverso il social network ad essere stati riscontrati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16712/2014, che ha ricondotto la fattispecie della diffamazione aggravata attraverso l’utilizzo del mezzo di pubblicità all’ipotesi di diffamazione attraverso il social network. Ha ribadito infatti la Corte di Cassazione che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato. E’ quanto è stato affermato dalla recente sentenza dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 50/2017), secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”. Oggi pertanto siamo attori e spettatori di un sistema che ci permette di inviare e di ricevere molteplici e differenti informazioni, grazie anche alla facilità e rapidità di accesso alla rete. I social network sono pertanto diventati l’ambiente virtuale più frequentato al mondo, dove ogni giorno milioni di persone interagiscono con gli altri, scambiandosi opinioni, foto, commenti e informazioni. L’azione più semplice di tutte, cioè l’esprimere un proprio pensiero o una propria opinione, racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale, che a volte vengono ignorate e che invece il buon senso e la corretta utilizzazione dei social network dovrebbero aiutarci a conoscere.
L’enorme effetto di “cassa di risonanza” delle informazioni pubblicate sul web, spesso a prescindere dalla loro effettiva veridicità, può risultare però alquanto pericoloso ogniqualvolta l’oggetto del messaggio diffuso abbia carattere denigratorio ed infamante nei confronti del suo destinatario. Oggigiorno, il danno subito da una vittima di diffamazione per il tramite di mass media (TV, web, giornali) o di social network (Facebook, Linkedin, Twitter) può assumere un’entità ben più consistente rispetto al passato, ragion per cui diventa fondamentale conoscere, ed intraprendere, tutte le possibili vie di tutela da al fine di tutelarsi dagli attacchi diffamatori subiti.
La Corte di Cassazione ha chiarito ad esempio che nell’ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip” -caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo- la continenza espressiva deve valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, la quale consente toni anche sferzanti purché non gratuiti e sempre pertinenti al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. pen., sez. V, 20/03/2019, n. 32829). Al contrario, in tema di esercizio dell’attività giornalistica, si è stabilito che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali sono l’accostamento e l’accorpamento di notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo (Tribunale Milano sez. I, 13/06/2019).
La reputazione di un’azienda, costruita in lunghi anni di impegno e sacrificio, è facilmente minacciata da comportamenti imprevedibili e subdoli, al limite del lecito, messi in atto per minare la credibilità dell’impresa.
La diffamazione è una condotta che mira intenzionalmente ad offendere e/o screditare la reputazione personale o aziendale, arrecando forti danni non soltanto economici, ma spesso tali da minacciare la stessa sopravvivenza dell’azienda.
Nell’economia digitale la diffamazione è avviene attraverso internet con false recensioni, calunnie o attribuzione di fatti non veri, nei quali l’autore è difficilmente identificabile. L’immagine aziendale è fortemente connessa e si esprime attraverso nuovi canali quali i social networks che, proprio in virtù della loro peculiarità di “fonte aperta”, sono facilmente manipolabili e consentono all’autore della diffamazione un notevole margine di occultamento.
Un comportamento scorretto da parte di un dipendente può causare una grave conseguenza, quella del danno aziendale.
Cos’è? È una vera e propria opera di infangamento della brand reputation di un’azienda a opera di comunicazioni negative costruite relativamente a quell’impresa. Sono dei comportamenti che tendono a minare la credibilità di un marchio. Può capitare, per esempio, che un dipendente approfitti delle occasioni di contatto con il pubblico per diffamare l’azienda presso cui lavora. Quando questo tipo di danno aziendale nasce proprio in seguito alle modalità appena descritte si ricade nell’illecito. Secondo l’articolo 2105 del Codice Civile, infatti, fra i vari obblighi che legano un lavoratore al suo datore di lavoro, vi è anche l’obbligo di fedeltà. Nel caso in cui un dipendente non rispettasse l’obbligo di fedeltà, viene meno il vincolo fiduciario, una condizione che può comportare contestazione disciplinare e giungere all’azione del licenziamento per giusta causa.
Quando viene a crearsi un rapporto di lavoro (o un generale accordo di collaborazione con una durata prestabilita o rinnovabile) tra datore di lavoro e dipendente, quest’ultimo è tenuto a rispettare una serie di obblighi che, seppure non esplicitati nel contratto, sono previsti dalla legge così come riportato in diversi articoli del Codice Civile (di cui è già stato citato il 2105). Un lavoratore è vincolato all’azienda tramite gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Mentre i primi due sono legati esclusivamente alla condotta del dipendente all’interno dell’impresa (per farla semplice, che deve svolgere gli oneri lavorativi assegnatigli così come previsti dal contratto che regola il rapporto fra le due parti), il terzo ricade unicamente sulla condotta del lavoratore. Quest’ultimo, secondo l’obbligo di fedeltà, non può diffamare l’impresa presso cui lavora. La conseguenza logica è anche prevedibile. Per dirla banalmente: provocando un danno aziendale, il marchio risente di un calo dei profitti che può andare a discapito del dipendente stesso, magari con licenziamenti o con tagli dei turni. Come può essere provocato questo danno aziendale? Attraverso qualsiasi condotta del dipendente che possa essere giudicata oggettivamente come comportamento sleale nei confronti dell’impresa, tale da pregiudicarne la reputazione.
All’obbligo di fedeltà sono infatti legati due corollari specifici:
– divieto di concorrenza
– dovere di riservatezza
Il divieto di concorrenza è abbastanza esplicito. Viene vietato, infatti, qualsiasi comportamento che sia in concorrenza con l’azienda. Per attività concorrenziali vanno a intendersi tutte le azioni che entrano in conflitto con il datore di lavoro, sia durante l’orario di lavoro che al di fuori. Questo divieto non viene rispettato ogni qualvolta si crei una situazione di competizione economica (non solo relativa alla clientela) con l’impresa che eroga il lavoro. Alcuni di questi casi possono essere la costituzione di un business che conduce attività simili all’azienda presso cui si lavora oppure l’assunzione dei lavoratori altrui o la prestazione extra-lavoro di servizi manuali specifici.
Il dovere di riservatezza è, come il punto precedente, altrettanto lapalissiano. Con questo punto si intende tutelare il datore di lavoro dal danno aziendale conseguente alla divulgazione o all’utilizzo di informazioni e di know how propri dell’impresa. Tutto ciò di cui il dipendente viene a conoscenza all’interno del luogo di lavoro, e che gli è necessario per svolgere le sue mansioni, non deve essere comunicato al di fuori dell’azienda. Notizie riservate e conoscenze specifiche dell’impresa, come i processi produttivi, non devono essere divulgati dal lavoratore. Spesse volte, per tutela, viene creato un vero e proprio contratto di riservatezza che, nel caso in cui non fosse rispettato, prevede sia sanzioni economiche sia disciplinari.
Il danno aziendale non è però circoscritto ai soli casi suddetti. Oltre, per esempio alla diffusione di notizie riservate, se il dipendente fa un uso smodato del diritto di critica può esservi una lesione dell’immagine aziendale. Altro caso in cui può verificarsi un danno all’impresa è quello della sottrazione del tempo lavorativo. Se, per esempio, durante le ore di lavoro previste dal contratto, il dipendente si dedica ad attività parallele e del tutto estranee a quelle dell’azienda, piuttosto che all’impiego per cui viene retribuito, queste attività sono considerate in conflitto con quelle del datore di lavoro, seppure non direttamente concorrenziali. Le minacce all’immagine del brand sono poi aumentate con internet: calunnie, diffamazioni e diffusione di fatti non veri possono compromettere anche la reputazione del più forte dei brand. Proteggersi contro questi pericoli è un passo fondamentale per garantire una lunga e fruttuosa attività alle imprese.
Spesso si crede che il dipendente debba limitarsi a fare solo le proprie mansioni: ad entrare puntuale e ad uscire non prima dell’orario di chiusura; a rispettare il regolamento aziendale e ad espletare, nel tempo a lui assegnato, le proprie mansioni ma che poi, fuori dal lavoro, è libero di fare e di comportarsi come vuole. Non è così. La giurisprudenza oggi è molto più orientata, rispetto a quanto non fosse un tempo, a tutelare anche il datore di lavoro e la sua immagine. I giudici hanno sottolineato più volte il concetto che il dipendente “ci deve tenere” all’azienda. In che modo? Evitando, anche all’eterno e fuori dall’orario di lavoro, contegni che possano danneggiarla, ad esempio screditando la merce o i servizi venduti, andando a dire che il capo è uno sfruttatore o commettendo dei reati che possano pregiudicare la reputazione dell’ambiente lavorativo (spaccio, prestito di denaro con usura per il funzionario di banca, ecc.). Non basta quindi, a chi viene assunto di fare ciò che gli dice il datore di lavoro per evitare il licenziamento e finire a ingrandire le file dei disoccupati: il dipendente deve tutelare l’immagine aziendale. Cerchiamo, qui di seguito di capire cosa significa questo concetto e cosa può pretendere il datore. Sanzionato per aver scritto un post su Facebook contro l’azienda. Licenziato per essere stato condannato in un processo penale. Trasferito per un forte litigio coi colleghi di lavoro. Quante volte abbiamo letto di provvedimenti disciplinari contro i dipendenti per questioni non strettamente collegate alle mansioni espletate. Il licenziamento disciplinare è dietro l’angolo tutte le volte in cui un determinato episodio può, in qualche modo, danneggiare la produzione. Tuttavia, il più delle volte, quando si dice che il dipendente deve tutelare l’immagine dell’azienda ci si riferisce all’astensione da specifiche condotte e non anche a comportamenti attivi. In altre parole, non è richiesto al dipendente farsi da promoter del proprio datore di lavoro, ma quantomeno di astenersi da tutto ciò che, anche indirettamente, può incidere sulla reputazione di quest’ultimo e dell’azienda stessa. L’elencazione di alcune sentenze ci agevolerà la comprensione di tale principio. Non si può parlare male dell’azienda e dei suoi prodotti o dei suoi dirigenti e, nello stesso tempo, lavorare per essa. È questo l’orientamento della Cassazione secondo cui pubblicare un commento denigratorio del datore di lavoro su Facebook può comportare il licenziamento. In particolare, secondo la Corte [11], la condotta di postare un commento su Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica. Con la conseguenza che, se lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del licenziamento, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.
APPROFONDIMENTI:
1. https://lacittanews.it/2021/04/02/ditta-europea-umilty-di-salvatore-luca-longo-oggetto-di-minacce-e-gogna-mediatica/
2. https://lacittanews.it/2021/05/12/la-corte-di-cassazione-accoglie-il-ricorso-degli-avvocati-dellimprenditore-luca-longo-adesso-si-attende-la-risposta-del-tribunale-di-palermo/
SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
https://www.btstudiolegale.it/cosa-sono-le-dichiarazioni-mendaci/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/diffamazione-sui-social-ecco-cosa-prevede-la-legge/
https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/28/diffamazione-via-mass-media-social-network-tutele-risarcimenti
https://www.captasrl.com/investigazioni-aziendali/danno-allimmagine-aziendale/
https://www.workengo.it/brand-reputation/danno-aziendale/
https://www.google.com/amp/s/www.laleggepertutti.it/amp/209092_il-dipendente-deve-tutelare-limmagine-aziendale